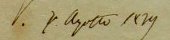
| BIOGRAFIE | 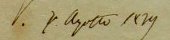 |
Firenze 1826-1891, erudito. Collaboratore di vari periodici, tra i quali «Il lampione», l’«Archivio storico italiano», la «Nuova Antologia», scrisse di storia letteraria, teatrale, musicale e soprattutto di tradizioni popolari toscane, romane e italiane in genere, illustrando con ampia documentazione, obiettività e garbata scrittura soprattutto il Seicento e il Settecento (Il carnevale di Roma nei secoli XVII e XVIII, 1883; Corilla Olimpica, 1887; I teatri di Roma nel sec. XVI, 1888, ecc.).
Alessandro LanariSan Marcello di Jesi 1790-Firenze 1862, impresario. Iniziò la carriera a Lucca nel 1821 e per oltre un trentennio, cioè quasi fino alla morte, fu appaltatore dei più importanti teatri lirici italiani, tra i quali l’Apollo e l’Argentina di Roma, la Scala e la Canobbiana di Milano, la Fenice e l’Apollo di Venezia, e il S. Carlo di Napoli; ma dedicandosi in modo particolare alla Pergola di Firenze, che diresse nelle stagioni 1823-28, 1830-35, 1839-48 e 1860-62.
Giovanni PaciniCatania 1796-Pescia 1867, musicista. Studiò a Roma, poi a Bologna con S. Mattei. Esordì come compositore a sedici anni. Visse specialmente a Lucca, maestro di cappella onorario a corte e direttore dell’Istituto musicale che oggi porta il suo nome. Tra le sue composizioni acquistarono larga fama le opere Saffo (1840), Medea (1843), La regina di Cipro (1846), Niccolò de’ Lapi (1855).
Luigia AbbadiaGenova 1821- Roma 1896, mezzosoprano. Figlia del compositore Natale Abbadia, studiò col padre e debuttò a Sassari nel 1836 nella Semiramide di Rossini; nel 1838 cantò a Mantova la parte di Agnese nella Beatrice di Tenda di Bellini; fece poi tournées in Italia e all’estero. Giovanni Pacini compose per lei la parte di protagonista di Saffo, rappresentata a Napoli nel 1840 e Gaetano Donizetti quella di Maria Padilla nell’opera omonima, rappresentata nel 1841 a Milano. Fu anche apprezzata interprete verdiana e wagneriana. Nel 1870, abbandonate le scene, diresse una scuola di canto a Milano, dove ebbe allievi cantanti che si affermarono, come Giovan Battista De Negri e Giuseppina Pasqua. Mezzosoprano che con gli anni si dimostrò anche un soprano di agilità, fu subito lodata dai contemporanei per le sue doti di attrice oltre che di cantante.
Marianna Barbieri NiniFirenze 1818-1887, soprano. Allieva dello zio Luigi Barbieri, studiò successivamente con Giuditta Pasta e con Nicola Vaccaj. Esordì con successo nella Lucrezia Borgia di Donizetti (Firenze, carnevale 1839-1840) e subito dopo fu alla Scala nel Belisario sempre di Donizetti. Da allora si esibì con successo sulle maggiori scene italiane, nonché a Vienna, Barcellona, Madrid, Parigi (1850) e Londra (1851). Dopo Teodulo Mabellini, che scrisse per lei Il conte di Lavagna (Firenze, 1843), e Pacini (Lorenzino de’ Medici, Venezia, 1845 e Merope, Napoli, 1847), Verdi la volle interprete dei Due Foscari (Roma, 1844), di Macbeth (Firenze, 1847), e del Corsaro (Trieste, 1848). Nel 1859 si ritirò dalle scene, dedicandosi all’insegnamento. Vedova del conte Nini di Siena, sposò in seconde nozze il pianista e compositore viennese Leopold Hackenzollner, che si dice abbia pubblicato una biografia della moglie (Le memorie di una cantatrice), ma che poi sparì, dopo di averne dilapidato il patrimonio, senza lasciare traccia di sé. Ridotta alla più completa miseria, la Barbieri Nini visse i suoi ultimi anni impartendo lezioni di canto, specialmente agli stranieri, in una soffitta di Firenze. Ebbe voce sonora e robusta ed ottima tecnica, nonché cospicue qualità drammatiche. La sua opera favorita fu la Lucrezia Borgia, che le consentiva di entrare in scena mascherata e di nascondere la non comune bruttezza del viso prima di aver conquistato il pubblico con la bellezza del canto.
Adelaide Borghi MamoBologna 1829-1901, mezzosoprano. Incoraggiata dai cantanti D. Donzelli e Giuditta Pasta, studiò canto con Matilde Festa, debuttando nel 1846 nel Giuramento di S. Mercadante all’antico Teatro de’ Pascolini di Urbino e conseguendo già alla prima rappresentazione un notevole successo. Il 25 apr. 1847 cantò in un grande concerto al Teatro Comunale di Bologna, insieme con il basso P. Marchesi e il clarinettista E. Cavallini. Per la stagione 1849-50 fu a Malta, dove conobbe il tenore spagnolo Miguel Mamo, che in breve tempo sposò, unendo il proprio cognome a quello del marito. Nel 1851 cantò a Napoli Malvina di Scozia di G. Pacini al Teatro S. Carlo e nel 1853 fu a Vienna. Di ritorno in Italia nello stesso anno, presentò in prima esecuzione L’alchimista di L. Rossi al Teatro del Fondo di Napoli e Alina di G. Braga e nel 1854 al Teatro S. Carlo Marco Visconti di R. Petrella: queste due ultime opere erano state scritte apposta per la Borghi Mamo. Dopo circa un decennio di ininterrotti successi in Italia, la B. si ritirò a Parigi, scritturata al Théâtre Italien, allora dominato dai grandi cantanti Erminia Frezzolini (con la quale stabilì subito un rapporto di fraterna amicizia), Giulia Grisi, E. Tamberlick, ecc. e seppe conquistarsi il pubblico parigino con le sue doti e un repertorio arduo e disparato. La sua più grande creazione fu quella della parte di Azucena nel Trovatore verdiano, eseguito per la prima volta in Francia il 23 dic. 1854 al Théâtre Italien e ripetuto nel 1856 all’Opéra in lingua francese, dove, però, non ottenne consensi favorevoli dalla critica. Ancora al Théâtre Italien nel 1860 cantò Margherita la mendicante di G. Braga, suo prediletto accompagnatore; il 12 aprile dello stesso anno fu applaudita all’Her Majesty’s Theatre di Londra nella parte di Eleonora nella Favorita di G. Donizetti, parte che ripeté nell’autunno al Comunale di Bologna e nel 1861 alla Scala di Milano. A Londra la B. si esibì pure in concerti e partecipò anche al Norwich Festival. Nel 1861 presentò alla Scala, in prima esecuzione, l’Espiazione di A. Peri e nel 1863 il Rienzi dello stesso autore. Cantò in seguito a Madrid (1863-64, 1866), a Genova (1869) e a Venezia (1871); verso il 1875 si ritirò dalle scene, dedicandosi all’educazione musicale dell’unica figlia, Erminia. Dopo alcuni anni trascorsi a Firenze, si trasferì a Bologna, dove morì.
Teresa BrambillaCassano d’Adda 1813-Milano 1895, soprano. Compì gli studi musicali al conservatorio di Milano e iniziò la sua carriera su piccoli teatri. Il 19 luglio 1833 cantò con successo al Teatro Carcano di Milano nella Beatrice di Tenda di Bellini e, in autunno, nelle Cantatrici villane di V. Fioravanti. Si recò quindi a Odessa, dove interpretò con ottimo esito il ruolo di Adalgisa nella Norma. Richiamata a Milano, nel 1837 prese parte, insieme con Marietta, alla cantata In morte di Maria Malibran (musica di Donizetti, Pacini, Mercadante, Vaccai e Coppola), eseguita al Teatro alla Scala per l’inaugurazione del busto di M. Malibran, e nello stesso anno fu a Torino. Nel 1838 si recò a Barcellona, poi, nel carnevale 1839-40, fu interprete al Teatro alla Scala delle Due illustri rivali di S. Mercadante (26 dic. 1839) e delle prime dei Corsari di A. Mazzuccato (15 febbr. 1840) e di Giovanna II di C. Coccia (12 marzo 1840). In seguito fu scritturata per i maggiori teatri italiani e stranieri, riportando ovunque grandi successi per la bellezza della voce, dal timbro pieno e armonioso, e per l’arte del suo canto, fiorito e appassionato, che le permisero d’eseguire con pari successo ruoli del repertorio lirico-leggero e di quello drammatico. Fu, infatti, una grande interprete verdiana.
Giulia De Filippi SanchioliNata da famiglia milanese nel 1819, mezzo-soprano e anche soprano. Suo padre, il dottor Giuseppe De Filippi, era medico stimatissimo, e servì nell'armata di Napoleone I, che lo fregiò della Legione d’Onore e della Corona di Ferro. Fu educata alla declamazione da Francesco Jannetti e al bel canto da Nicola Vaccaj. Il Vaccaj stesso volle assistere al suo debutto, nella Norma, avvenuto il 2 ottobre 1844 al Teatro Apollo di Roma. Cantò prima al Teatro S. Carlo di Napoli, poi alla Fiera di Cremona, quindi al Her Majesty’s Theatre di Londra, dove nel fra il 1846 e il 1847 interpretò il Nabucco di Verdi e La favorita di Donizetti. Lavorò inoltre nei teatri di Palermo, Barcellona, Genova, Torino, Venezia, Firenze. Apprezzata in modo particolare per le sue doti di esperta attrice ben evidenziate nell’eccellente interpretazione del personaggio di Fede nel Profeta di Giacomo Meyerbeer, la Sanchioli è nota fra l’altro per la relazione che ebbe con lo scrittore Carlo Collodi fra il 1856 e il 1857.
Giuseppina StrepponiLodi 1815-Sant’Agata [PC] 1897, soprano. Il suo vero nome era Clelia Maria Josepha e proveniva da una famiglia di Lodi dedita alla musica: il padre, Feliciano, era compositore. Terminato il Conservatorio a Milano, esordì, proprio a Lodi, nell’Elisir d’amore. Affermatasi ben presto in campo teatrale, nel 1835 fu a Vienna per la sua prima tournée, riscuotendo, di lì a quattro anni, un grande successo alla Scala di Milano. Dotata di talento e sensibilità non comuni, fu intelligente interprete di alcune opere di Giuseppe Verdi: contribuì, con la sua performance, alla trionfale prima di Nabucco, del 1842, e alla rappresentazione di Ernani, del 1844. Ma la salute malferma e le fatiche di una vita intensa e disordinata non le permisero che una carriera di breve durata. La sua fama resta legata soprattutto al ruolo di seconda moglie di Giuseppe Verdi. Con il grande compositore la Strepponi convisse dal 1848 al 1859, anno al quale risale il loro matrimonio. Giuseppina accompagnò intelligentemente il Maestro nella feconda attività artistica e nella appartata vita privata a Villa Sant’Agata, presso Busseto, fino al 1897, anno della morte.
Carolina UngherStuhlweissenburg 1803-Firenze 1877, soprano. Debuttò a Vienna nel 1819 nel ruolo di Cherubino ne Le nozze di Figaro di Mozart, ed è rimasta celebre come la prima interprete della parte di contralto nella Sinfonia n. 9 di Beethoven. Scritturata da Barbaja, venne in Italia e cantò con successo a Napoli, Milano, Torino e Roma. Nell’ottobre 1833 debuttò al Théatre-Italien di Parigi e fu applaudita. Ciò nonostante, non conquistò in maniera definitiva l’approvazione del pubblico, e la scrittura non venne rinnovata. Tornata in Italia, la Ungher divenne una delle cantanti drammatiche più apprezate dell’epoca. Cantò a Firenze, dove ebbe un successo completo; poi a Venezia, Roma, Trieste, Vienna, Dresda (1839), e di nuovo a Trieste e Firenze. Oltre che della Maria de Rudenz di Donizetti a Venezia nel 1838, Carolina Ungher fu la prima interprete per Donizetti del Borgomastro di Saardam (Napoli, 1827), degli Esiliati in Siberia (revisione di Otto mesi in due ore data a Roma nel 1832), della Parisina (Firenze, 1833), e del Belisario (Venezia, 1836); per Bellini della Straniera (Milano, 1829) nel ruolo di Isoletta; e per Mercadante delle Due illustri rivali (Venezia, 1838). Partecipò inoltre alle prime rappresentazioni di tre opere di Pacini (Niobe, Napoli, 1826, I cavalieri di Valenza, Milano, 1828, e Furio Camillo, Roma, 1840). Per Nicola Vaccaj fu la prima (ed unica) interprete del ruolo di Donna Isabella nella Sposa di Messina (Teatro La Fenice, Venezia, 1839). Nel 1841 sposò Francois Sabatier e si ritirò dalle scene.